Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
Featured
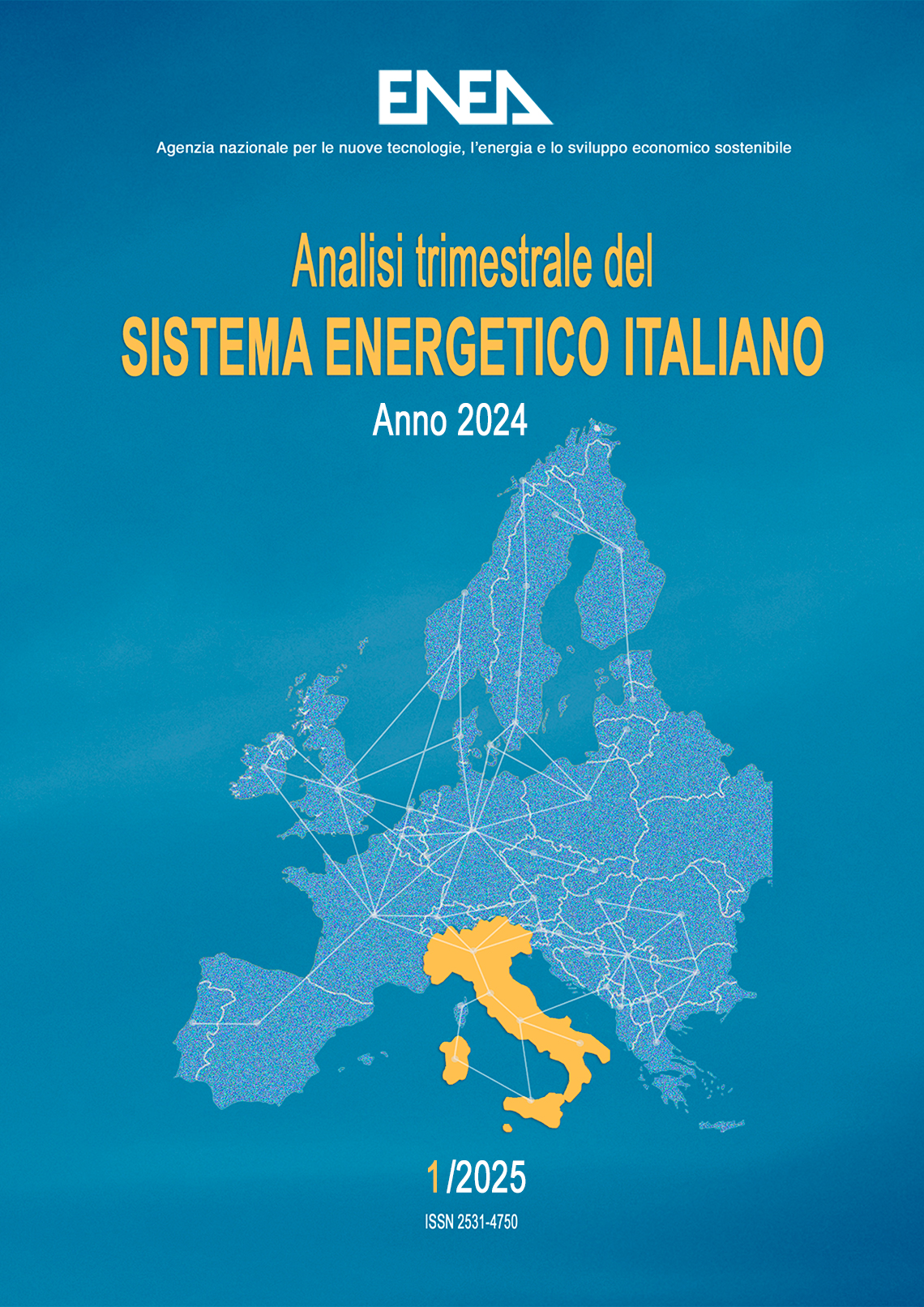
Analisi Trimestrale del Sistema Energetico Italiano - Anno 2024
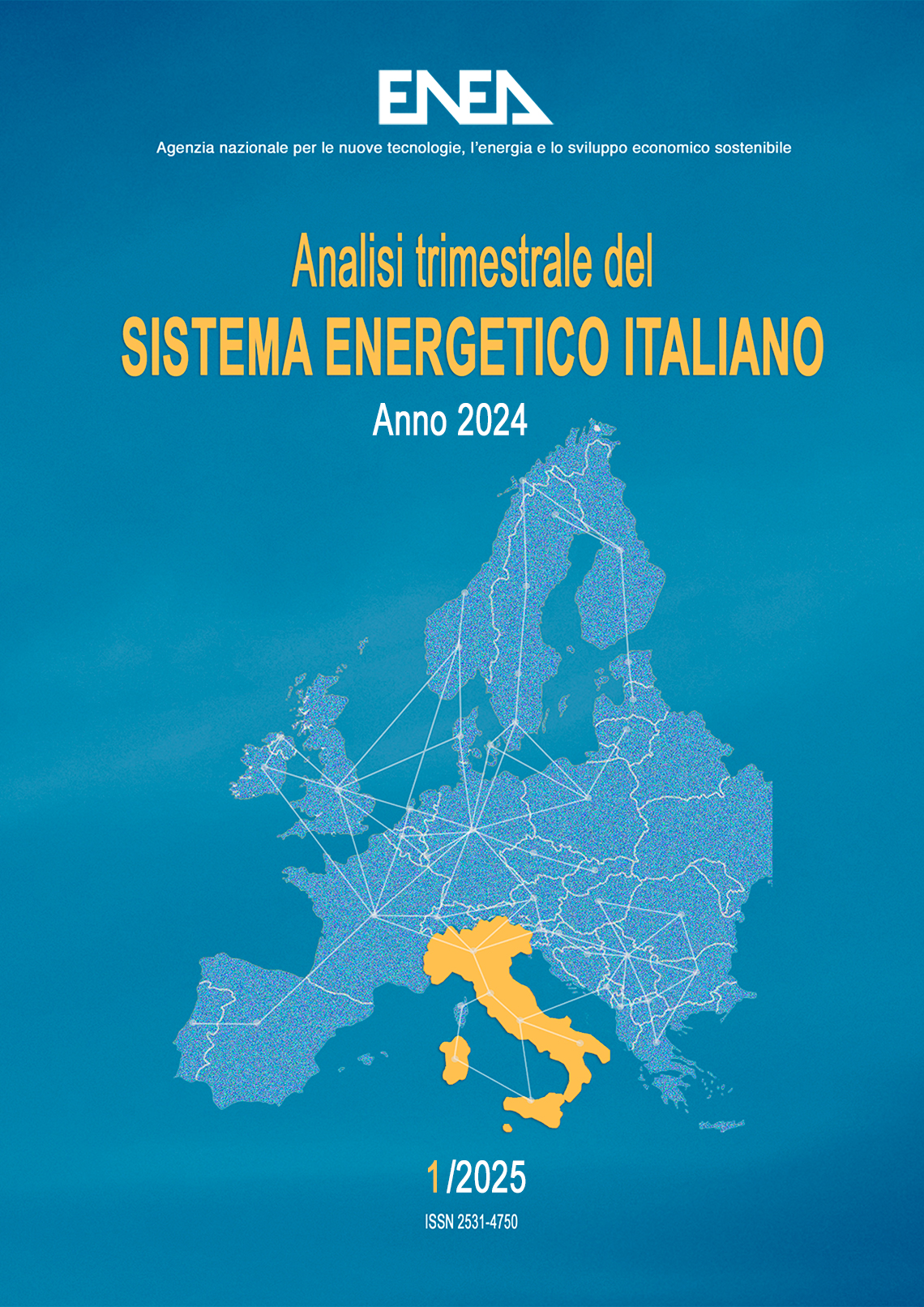
Leggi il report
Dimensione: 1.19 MB
SINTESI DEI CONTENUTI
Nell’area euro persistono quadro economico debole e alti prezzi dell’energia ma gli obiettivi su energia e clima 2030 continuano ad allontanarsi: marginale il calo dell’energia primaria, insufficiente quello delle emissioni di CO2
- Lo scenario economico-energetico dell’area euro resta caratterizzato da crescita economico debole, crisi dell’industria e alti prezzi dell’energia, dunque un contesto favorevole alla riduzione dei consumi energetici e alla decarbonizzazione, ma gli obiettivi su energia e clima 2030 continuano ad allontanarsi.
- La crescita economica dell’area è rimasta molto modesta anche per tutto il 2024 (+0,7% rispetto al 2023), mentre sui mercati dell’energia il prezzo del gas ha subito nel 2024 una nuova flessione (-15% al TTF), ma è rimasto maggiore di circa il 60% rispetto alla media 2010-’20 e pari a quattro volte il prezzo sul mercato USA. Anche i prezzi dell’elettricità hanno subito una flessione su base annua (-15% sulla borsa italiana, -40% sulla borsa francese), ma anch’essi restano molto al di sopra delle medie di lungo periodo, con rialzi consistenti nell’ultimo trimestre (fino a ben oltre i 100 €/MWh in Italia).
- I consumi di energia primaria dell’eurozona sono stimati in calo marginale, pari a circa mezzo punto percentuale. Tra le fonti si segnalano un nuovo drastico calo dei consumi di carbone (-14%) e una contrazione del petrolio (-1,5%). Si è invece fermato il calo dei consumi di gas, rimasti invariati, ed è aumentata ancora la produzione di elettricità da rinnovabili e nucleare (+5%).
- La concentrazione del calo dei consumi di energia sulle due fonti fossili più carbon intensive ha permesso di ridurre le emissioni di CO2 (-3,5%) in misura molto maggiore della riduzione dei consumi. Ciononostante, il calo delle emissioni è stato pari a quasi la metà di quello che sarebbe stato necessario per spostare la traiettoria delle emissioni su quella coerente con il target 2030, che dunque a fine 2024 risulta più lontano di quanto fosse un anno fa: serve ora una riduzione media annua di circa il 7%.
In Italia dinamica simile all’eurozona ma sono tornati ad aumentare i consumi finali, guidati da trasporti e civile (+3% circa)
- La dinamica di fondo del sistema energetico italiano resta simile a quella dell’eurozona, ma nel corso del 2024 in Italia i consumi di energia sono perfino tornati su una traiettoria ascendente, e il calo delle emissioni è risultato inferiore a quello dell’eurozona. Nell’insieme dell’anno i consumi di energia primaria (stimati con la metodologia Eurostat, come nel caso dell’eurozona) risultano in calo marginale (-0,5% circa), ma è forse più significativo il dato dei consumi finali di energia (che non risente della convenzione adottata per stimare l’energia primaria), che risultano in aumento di oltre l’1%[1].
- A trainare la ripresa dei consumi energetici sono soprattutto i trasporti (+3%), grazie alla continuazione della vivace dinamica della mobilità (sia stradale sia aerea), in aumento per il quarto anno consecutivo e ormai ben maggiore dei livelli pre-Covid. Sono in significativo aumento anche i consumi del settore civile (+2,5%), perché sono tornati a salire i consumi di gas per riscaldamento (in linea con il clima) e ha registrato aumenti significativi la domanda di elettricità del settore dei servizi (+4%). Restano invece in deciso calo i consumi energetici industriali (-3%), in linea con la performance ancora molto negativa della produzione industriale (-3,7% quella dei beni intermedi, più energivori).
- La dinamica della domanda di energia è risultata dunque ancora sostanzialmente coerente con quella dei suoi principali driver (PIL, produzione industriale, mobilità, clima). Come evidenziato più volte nell’Analisi trimestrale ENEA, questo dato conferma come le pur notevoli riduzioni dell’intensità energetica dell’economia registrate nell’ultimo biennio derivassero in misura solo molto parziale da cambiamenti strutturali del sistema verso una direzione meno energivora.
- In termini di fonti, il 2024 ha visto un altro drastico calo dei consumi di carbone (-2,5 Mtep), dimezzati rispetto al 2023 e ormai ridotti a un ruolo marginale, in particolare nella termoelettrica (dove rappresentano l’1% della domanda), mentre sono aumentati i consumi di tutte le altre fonti: +1,2% il petrolio, +0,8% il gas, +12% le rinnovabili (spinte soprattutto dalla ripresa dell’idroelettrico). Infine, sono rimaste pressoché invariate le importazioni nette di elettricità.
Emissioni di CO2 in calo (-2,5%) grazie al carbone ormai ai minimi termini nella termoelettrica (-70%), ma sono tornate a salire nel II semestre (+1,5%)
- La progressiva ripresa dei consumi di energia nel corso del 2024 si è riflessa nella dinamica delle emissioni di CO2, che nella seconda parte dell’anno sono tornate a salire (di oltre il 2% nel IV trimestre 2023, +1,5% nel II semestre), dopo otto variazioni trimestrali tendenziali negative. Nell’insieme dell’anno le emissioni sono stimate in contrazione di poco meno del 3% rispetto al 2023, a fronte del calo di oltre l’8% stimato per il 2023 (rispetto al 2022).
- Il calo delle emissioni è tutto ascrivibile al settore elettrico (-17%, ma +6% nell’ultimo trimestre), per il crollo dei consumi di carbone (-70%), a cui si è aggiunto un calo dei consumi di gas molto più modesto (-1,6%, a fronte del -16% del 2023). Nel settore elettrico la quota di generazione da fossili rispetto alla domanda è scesa al 47%, nuovo minimo storico, inferiore di 4 punti percentuali rispetto al precedente minimo storico del 2023.
- Sono invece tornate ad aumentare (+1%) le emissioni dei settori non-ETS (industria non energivora, terziario, residenziale e trasporti), spinte dalla dinamica dei consumi energetici dei trasporti e del civile.
Transizione energetica italiana in forte difficoltà, indice ISPRED al minimo storico per i target di decarbonizzazione mai così lontani e i prezzi elevati dell’energia
- Nel corso del 2024 l’indice ENEA ISPRED (Indice Sicurezza energetica, Prezzi energia, Decarbonizzazione), che valuta l’andamento della transizione energetica italiana sulla base di un ampio insieme di indicatori rappresentativi delle tre dimensioni del cosiddetto trilemma energetico, si è ridotto del 25%, e a fine anno si colloca sul livello più basso della serie storica.
- Il peggioramento dell’indice della transizione è dovuto interamente alla dimensione Decarbonizzazione, per il dato molto negativo delle emissioni dei settori non-ETS, che per centrare il target 2030 nei prossimi sei anni dovrebbero ridursi del 5% medio annuo, a fronte del -1% degli ultimi cinque anni. Ma anche la crescita delle fonti rinnovabili, nonostante il forte aumento delle installazioni di impianti fotovoltaici (+6,8 GW, un dato inferiore solo all’aumento record del 2011), resta decisamente inferiore a quella coerente con il target 2030: a fine 2024 la quota di rinnovabili sui consumi finali è stimata al 20%, un dato già molto inferiore alla traiettoria delineata nel pur recente PNIEC, che per il 2024 prevedeva una quota del 22,6%.
- Con riferimento alla dimensione Prezzi dell’energia e competitività dell’industria il 2024 si segnalano due dati decisamente negativi: il deciso ampliamento del premio del prezzo dell’elettricità sulla Borsa italiana (108 €/MWh la media annuale) rispetto a quelli dei principali mercati elettrici europei (78 €/MWh in Germania, 63 €/MWh in Spagna, 58 €/MWh in Francia), e il nuovo aumento dello spread tra il prezzo del gas sul mercato italiano (PSV) e quello di riferimento europeo (TTF), che nella seconda metà dell’anno è tornato anche a superare i 3 €/MWh, un valore non spiegabile con i costi di trasporto tra i due hub. La dinamica di medio periodo della produzione industriale dei settori più energy intensive resta inoltre decisamente peggiore di quella dell’insieme dell’industria manufatturiera, sebbene nel 2024 la flessione dei primi sia stata più contenuta.
- Infine, riguardo alla Sicurezza energetica, nonostante la (leggera) ripresa del 2024 i consumi di gas sono rimasti sui minimi di lungo periodo, e inferiori di oltre il 20% rispetto al massimo degli ultimi quindici anni, per cui anche il margine di adeguatezza del sistema è rimasto su decisamente maggiori rispetto ai livelli critici raggiunti più volte nell’ultimo decennio, sebbene ancora potenzialmente problematici in caso di situazioni estreme come l’azzeramento dei flussi di gas russo via pipeline, inverno molto freddo e bassa disponibilità di GNL. Lato petrolio, invece, un dato rimarchevole del 2024 è il calo del tasso di utilizzo delle raffinerie e della quota di consumi di gasolio e benzina coperta con produzione interna.
Si ferma l’aumento del deficit commerciale italiano nelle tecnologie low-carbon, in primis grazie al crollo dei costi unitari dei pannelli fotovoltaici importati
- A quasi chiusura del 2024 si rileva infine una significativa battuta d’arresto del continuo e forte peggioramento registrato nell’ultimo quinquennio dalla posizione debitoria dell’Italia sull’estero delle tecnologie energetiche per la decarbonizzazione, con un passivo commerciale che scende da circa 6,4 a poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro su base annuale (da novembre 2023 a novembre 2024). Il dato sottende tuttavia anche importanti modifiche del contributo all’interscambio complessivo da parte dei comparti di maggior peso, con ampie variazioni dei valori di importazione riconducibili tanto a fattori di domanda (collegati a mutamenti dell’attività produttiva interna) quanto ad effetti di prezzo. Rispetto al quadro della domanda si segnala in particolare un quasi raddoppio del deficit commerciale relativo alle auto a basse emissioni (che passa da circa 1,3 a poco meno di 2 miliardi e mezzo di euro, con un apporto determinante della forte crescita delle importazioni nette di veicoli elettrici BEV associata al crollo del 66% delle esportazioni nel contesto delle difficoltà produttive del settore auto), a cui fa da contraltare una riduzione superiore al 40% del deficit del comparto degli accumulatori, che si attesta su un valore di poco inferiore ai 2 miliardi di euro (a fronte degli oltre 3 miliardi dell’anno precedente) in seguito alla caduta delle importazioni degli accumulatori agli ioni di litio. All’operare preponderante di effetti di prezzo va ricondotta invece la consistente contrazione del valore del deficit relativo al fotovoltaico (poco più di 1 miliardo di euro, pari a un quasi dimezzamento rispetto al valore del 2023), che sottende una caduta dei valori medi unitari all’import diventata particolarmente incisiva nel corso del 2024 (-37% rispetto al 2023). Nel settore delle energie rinnovabili continua altresì a deteriorarsi la posizione commerciale dell’eolico, con un forte balzo delle importazioni dei sistemi a torre e l’emergere di un passivo commerciale a livello di comparto di circa 147 milioni di euro.
[1] La differenza tra le stime prodotte dai due metodi è legata alla convenzione adottata per la valorizzazione dell’elettricità da fonti rinnovabili: il metodo del “physical energy content”, utilizzato per i bilanci Eurostat, o il “partial substitution method”, utilizzato per i bilanci energetici pubblicati fino al 2018 dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’attuale Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. N.B.: nel capitolo 2 dell’Analisi trimestrale ENEA la serie storica dei consumi di energia primaria è ricostruita valorizzando l’elettricità rinnovabile con il “partial substitution method”, per coerenza con la serie storica dei bilanci energetici prodotti dal Ministero italiano.
